febbraio 23, 2011
di scrittoriprecari
Sull’ironia sono stati scritti trattati a non finire. Credo sia ironia anche questa: scrivere all’infinito su qualcosa che non si può descrivere. E scrivere all’infinito significa impedire di leggere e capire qualcosa.
Sull’ambiguità tutti concordano nel dire che sia essenzialmente seduttiva: la donna che si vela, la luce soffusa, il vedo-non-vedo, l’ammiccamento, etc.
Elementi differentissimi, sembrerebbe. Sembrerebbe…
Ma esaminiamoli meglio.
L’ironia è un concetto polivalente: finzione e disvelamento della verità tramite la finzione. Ma formalmente finzione. Deduzione ovvia, che nel Volo diventa teodicea assiomatica: la verità si esprime tramite la finzione, posso meglio indovinare le fattezze dell’attore vedendolo in scena mentre si finge chi non è piuttosto che sentendomele descrivere direttamente da lui al telefono.
Tramite questo assioma arriviamo direttamente al secondo termine del teorema: l’ambiguità. La verità, che vive nel reale (la teoria di Tarski è che siano veri solo i predicati riferiti ai soggetti al modo indicativo), è ambigua tanto quanto il reale stesso: come dire, in un milione di metri cubi di banane tutte le banane si somigliano e non c’è praticamente differenza fra la banana buona e quella così così. Insomma, per scoprire la verità ci serviamo della finzione, ma così tutti i fatti – annacquati in un così così di verità e falsità – diventano ambigui, mezzi falsi e mezzi veri.
Il Volo è l’espressione di questo ragionamento.
Esiste la verità? La letteratura può raccontarla? Può uno scrittore cambiare?
La verità non esiste o almeno non è alla portata degli uomini. E qui, come motivazione, si potrebbe addurre qualche bel sofisma del tipo: la verità vera è solo coincidente con l’Assoluto (o Dio o Vattelappesca), quindi preclusa alla finitezza umana. Raffinato, se vogliamo. Ovviamente i sofismi ci piacciono e ne facciamo largo uso, ma stavolta affidiamoci al dogma: la verità, almeno nelle cose umane, non esiste. E non esiste perché è la razionalità stessa che la uccide. Esempio: l’omicidio a livello istintivo è sentito come un’azione che merita una punizione equipollente, ma a livello morale e razionale e culturale si disconosce una simile eventualità e l’assassino finisce in galera o viene giustificato in via politica o ideologica o sociologica o antropologica o psichiatrica o etc.
Va da sé che la letteratura è arbitraria tanto quanto la verità. E sono proprio i libri razionali come il Volo che uccidono la verità coi raffinati ragionamenti e le adulterazioni dell’intelletto (le sue “astuzie” direbbe qualcun altro). La letteratura non racconta la verità, ma piuttosto una disposizione di eventi interiori ed esterni a cui dare una direzione e una meta qualunque. Meta che poi viene spacciata per verità, perché – come dicevo altrove – ogni scrittore è un dittatore mancato.
Infine: uno scrittore può cambiare? – questa è la domanda più affascinante. Moravia diceva, e io – in linea di massima – condivido, che uno scrittore è come un uccello: ripete il suo verso, può modificarlo, ma il verso è quello. Il vero Scrittore, maiuscolo, può solo ripetersi. La differenza fra uno scrittore mercificato che si ripete in serie e uno Scrittore maiuscolo che ripete il suo verso (il talento fa quello che vuole, il genio quello che può) è che lo scrittore mercificato annoia e lo Scrittore maiuscolo affascina. Uno Scrittore sostanzialmente non cambia. Stephen King cambia, ma perché lui è un tecnico talentuoso della sua materia (ma perfino lui non cambia l’eptalogia La Torre Nera); Liala non cambia, ma non perché è una Scrittrice, bensì perché non può cambiare per l’ossessività insita nel suo tema, che disponendo d’infiniti potenziali intrecci imprigiona l’autrice; l’immenso Dostoevskij non cambia e non annoia, per la buonissima ragione che lui, di libro in libro, mantenendo il suo tema, cerca d’ibridarlo con ciò che vede intorno a sé e lo interessa al di là del tema.
Il Volo è il prototipo di ogni mio libro, che conserva allo stesso tempo l’impostazione del concept work e la frammentarietà dell’ispirazione, il linguaggio freddo e distaccato del raziocinio e la liricità dell’ego, oggettività e soggettività: perché, dopo aver descritto l’equazione, il gusto è commentarla partendo da quel pozzo di soggettività che, indiscutibilmente, come ogni autore, mi porto dentro.
A questo punto bisognerebbe spiegare cos’è il Genio – in letteratura. È un contenuto geniale? Una forma geniale? È innovazione?
Il Genio in letteratura è riuscire a creare addosso a un’idea qualunque un linguaggio che gli si adatti perfettamente e riesca a traghettarla dalla sua astrattezza alla concretezza del momento particolare. La prolissità di King crea suspense, l’aridità di Moravia esprime meglio di tutto il pensiero analitico (per non parlare di una letteratura improntata al realismo socialista), le pirotecnie di Joyce esprimono il tumulto dell’interiore e il tomismo e gli accidenti sbalestranti del fenomeno, etc.
In letteratura un’idea geniale non crea il Genio, così come non lo crea una forma geniale. Il nodo, il raccordo, la congiunzione fra idea e modo di esprimerla crea il Genio. Il Genio non può che darsi in via combinatoria.
Ecco perché un Genio, fin dalle prime battute, anche se è indefinito o ancora impacciato, è riconoscibile.
Bisogna, però, arrivati a questo punto, fare una precisazione: il libro Geniale non è detto che venga partorito da un Genio, ma il Genio produrrà sempre un libro geniale.
A questo punto l’ultima domanda: a cosa è servito quello che fin qui avete letto?
Neanche a questo uno scrittore può rispondere.
Antonio Romano

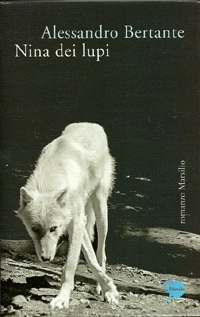



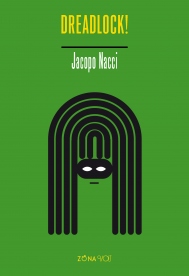
Commenti recenti